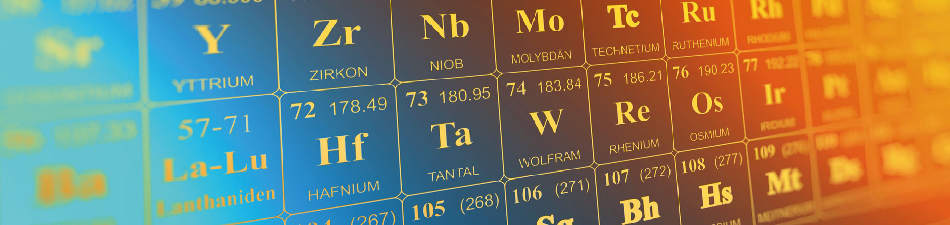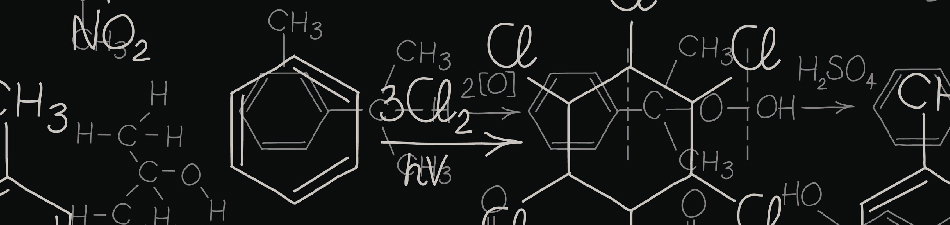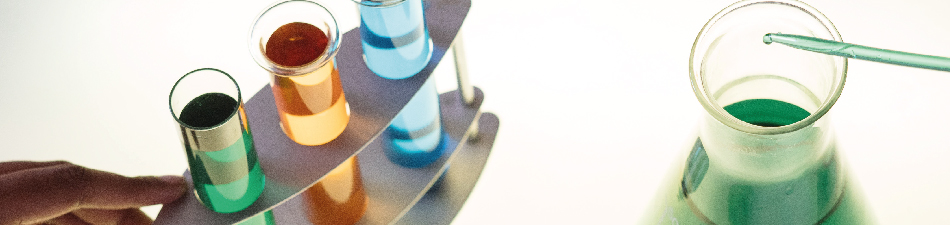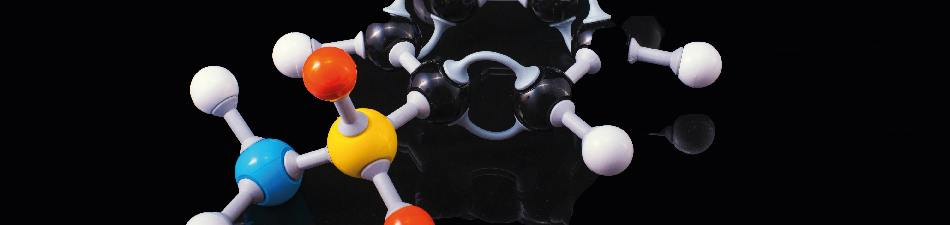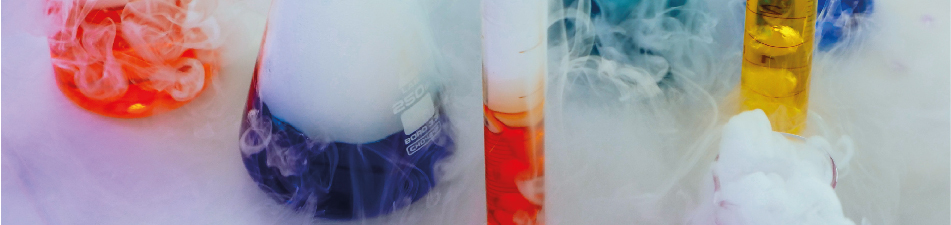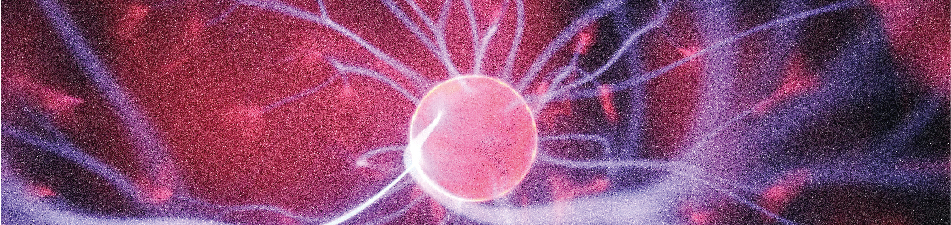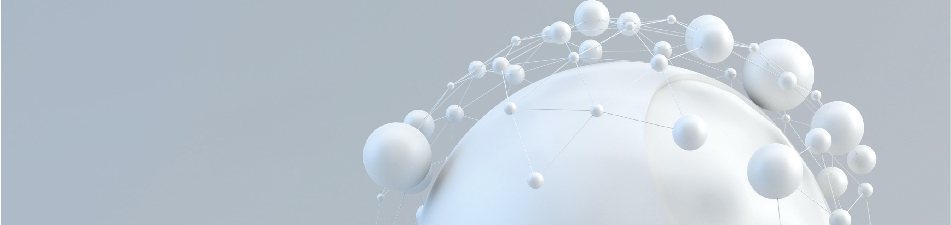Aggregatore di feed
I frutti climaterici
Claudio Della Volpe
La parola greca climatèrio s. m. [dal gr. κλιμακτήρ, propr. «gradino», der. di κλῖμαξ «scala»; per il sign., cfr. climaterico] (dalla Treccani), si riferisce in genere alla vita sessuale di uomini e donne, e in particolare al momento della vita in cui si ha riduzione o scomparsa della fertilità nei due generi con tutta una serie di eventi annessi.
Tenete presente che la seconda k della parola greca si conserva nell’inglese, in cui si scrive il sostantivo climacter o l’aggettivo climacteric, NON climateric, mentre in italiano la seconda k è scomparsa.
Ma quello di cui vi parlerei oggi non è il climaterio umano ma quello vegetale; infatti nella maturazione dei frutti sulla pianta o dopo la raccolta si verificano dei fenomeni molto interessanti cui fa riferimento questo termine.
I frutti climaterici sono quelli che anche dopo essere stati raccolti producono una significativa quantità di etilene, un gas ben conosciuto ai chimici per il suo ruolo nell’industria dei polimeri, ma anche ai biochimici per il suo ruolo di ormone vegetale.
Un secondo avviso lo metterei per la confusione che a volte si fa nei giornali o nel parlar comune fra etilene ed ossido di etilene, due sostanze affatto diverse e riportate qui sotto!

Etilene

Ossido di etilene
L’ossido di etilene è una sostanza estremamente reattiva (basta considerare la tensione dell’anello a tre termini!) e considerata cancerogena almeno in Europa, tanto da non essere più usata in determinati contesti; tuttavia dato che continua ad essere usata in altri paesi, per esempio come antibatterico e fumigante, i suoi residui possono rimanere nei prodotti anche alimentari poi importati; dunque attenzione a questa distinzione. Un contenitore metallico di un TIR reso sterile tramite ossido di etilene potrebbe diventare una sorgente di inquinamento dei prodotti poi trasportati a meno di non ripulirne le superfici con altri gas.
Torniamo all’etilene, che pure è esplosivo o asfissiante ma non tossico o cancerogeno, tanto da potere essere usato come gas anestetico.
È un intermedio chiave nell’industria polimerica, ma anche come dicevo un ormone, dunque una sostanza di controllo delle piante, di origine del tutto naturale in quel caso.
Bella questa centralità della piccola molecola di etilene sia nell’attività umana che in quella naturale, questa duplice natura di una molecola che è poi un fenomeno comune ed importante in Chimica. Ne abbiamo parlato parecchie volte e avrebbe fatto contento Guido Barone ed anche Hegel o Marx.
L’etilene non agisce direttamente su un singolo enzima, ma stimola la sintesi di diversi enzimi, tra cui cellulasi e poligalatturonasi, che degradano le pareti cellulari durante i processi come la maturazione dei frutti e l’abscissione (ossia la caduta di foglie e frutti). L’etilene regola anche la propria stessa produzione, essendo prodotto dall’enzima ACC-ossidasi che converte l’ACC (acido aminociclopropancarbossilico, che è un amminoacido NON proteico, cioè che non si trova nelle proteine) in etilene.

acido ammino-ciclo-propan-carbossilico
Quali sono i frutti che producono più etilene e quali sono quelli più sensibili al suo effetto? C’è stato molto lavoro su questo tema a cavallo del nuovo millennio e una review particolarmente citata è quella del 2002 di Kader, elencata in fondo, da cui possiamo estrarre le tabelle seguenti e anche lo schema temporale dell’azione dell’etilene. I frutti che risentono dell’azione dell’etilene si chiamano frutti climaterici; ovviamente l’etilene può incrementarne la maturazione ma anche portarla oltre i limiti di uso utile del frutto o del vegetale, dunque è importante regolare con attenzione le condizioni di utilizzo pratico, od eventualmente associare altri ormoni gassosi ad azione antitetica, oppure usare comuni molecole come ossigeno e CO2, già presenti in ambiente la cui concentrazione agisce sul ciclo dell’ormone, come indicato dopo, anche perché la curva di azione è complessa come si vede qui sotto.

Lista di comuni frutti e vegetali climaterici e non-climaterici.

E tenete presente che ci sono frutti che producono poco etilene ma sono molto sensibili alla sua azione e anche frutti non climaterici, ossia che non continuano a maturare una volta raccolti dalla pianta, poiché non hanno la capacità di produrre etilene in modo autonomo. Invece di maturare dopo la raccolta, questi frutti si possono deteriorare se acquistati acerbi. Esempi comuni includono agrumi (arance, limoni), frutti di bosco (fragole, ciliegie, lamponi), l’uva, l’ananas, i melograni, le olive, e anche alcuni ortaggi come cetrioli e peperoni.
Potreste trovare elenchi non completamente coincidenti perché l’azione e la produzione dell’etilene dipendono dal contesto sperimentale usato.
In modo parallelo ma opposto all’etilene il metil-ciclopropene si comporta da ritardante della maturazione e dunque può essere usato per mantenere fiori e frutti maturi prevenendo il loro deterioramento

In conclusione attenzione a come mettete la frutta e i vegetali insieme in frigo o nella dispensa, perché potreste avere effetti inattesi e non necessariamente vantaggiosi.
Dopo tutto sono ancora vivi quando li conserviamo.
Consultati:
Kader, A.A. (2002) Postharvest Technology of Horticultural Crops. 3rd Edition, University of California, Agriculture and Natural Resources, Oakland, Publication 3311, 535 p., Kader, AA.
Etilene: l’ormone gassosoMachine learning-guided engineering of chalcone synthase enables high-selectivity phloretin biosynthesis in yeast
DOI: 10.1039/D5GC03435C, PaperMei Li, Canyu Zhang, Hui Liang, Boyang Wu, Wenxi Yu, Guangjian Li, Yufei Cao, Wen-Yong Lou
Machine learning-guided engineering of chalcone synthase effectively overcomes substrate promiscuity, enabling highly selective biosynthesis of phloretin in yeast, and provides a framework for the microbial production of high-value natural products.
The content of this RSS Feed (c) The Royal Society of Chemistry
Efficient Synthesis of Covalent Organic Frameworks in Supercritical Carbon Dioxide and their Application in Iodine Capture
DOI: 10.1039/D5GC05101K, PaperHai Jiang, Shenglin Wang, Bin Zheng, Xiaofang Su, Muhammad Naveed Javed, Hui Hu, Huanjun Xu, Yanan Gao
Covalent organic frameworks (COFs) are commonly synthesized via solvothermal methods at high temperatures for more than 72 hours, utilizing hazardous organic solvents as reaction medium. Here, we propose a methodology...
The content of this RSS Feed (c) The Royal Society of Chemistry
Enhanced catalytic aminolysis of polyethylene terephthalate plastic wastes via zeolite acid-base sites regulation
DOI: 10.1039/D5GC04043D, PaperXiaoqin Si, Meng Wu, Yifan Niu, Kanglin Hou, Mengping Fan, Xin Liu, Chen Sun, Tianliang Lu
The catalytic aminolysis of polyethylene terephthalate (PET) plastic wastes to the value-added diamine products plays an increasingly significant role in the sustainable environment and energy development. Herein, Na-ZSM-5-70 zeolite was...
The content of this RSS Feed (c) The Royal Society of Chemistry
Two-step chemolytic delamination and depolymerization of multilayer laminated packaging films into valuable chemicals
DOI: 10.1039/D5GC02780B, PaperKalsoom Jan, Taofeng Lu, Christian Ayafor, YuanQiao Rao, Junho Jeon, Junsi Gu, Maria C. Folgueras, Hsi-Wu Wong, Wan-Ting Grace Chen
The mechanical recycling of multilayer laminated packaging films (MLPFs) is considerably challenging due to their compositional heterogeneity and their diversity in adhesives. To address this challenge, this study uses a...
The content of this RSS Feed (c) The Royal Society of Chemistry
Closed-Loop Upcycling of PET Waste into Defect-Engineered Ni@C Electrocatalysts for Efficient Formate Production
DOI: 10.1039/D5GC04403K, PaperRui Qin, Chenyang Wei, Yijun Yin, Zhaohui Yang, Shao Wang, Yurun Tian, Lan Chen, Zhimin Xue, Tiancheng Mu
To address the challenges of polyethylene terephthalate (PET) recycling, we propose a closed-loop upcycling system based on deep eutectic solvent (DES) mediated alkaline hydrolysis PET into terephthalic acid (TPA) and...
The content of this RSS Feed (c) The Royal Society of Chemistry
Artificial intelligence-driven dynamic regulation for high-efficiency gentamicin C1a production
DOI: 10.1039/D5GC02507A, PaperFeng Xu, Yuan Wang, Hao Gao, Kaihao Hu, Rong Ben, Ali Mohsin, Yuanxin Guo, Xu Li, Hui Wu, Haifeng Hang, Ju Chu, Xiwei Tian
The industrial biosynthesis of complex antibiotics such as gentamicin C1a requires precise, dynamic control of microbial metabolism.
To cite this article before page numbers are assigned, use the DOI form of citation above.
The content of this RSS Feed (c) The Royal Society of Chemistry
Green and sustainable itaconic acid-based vitrimers with rapid stress relaxation, superior fire safety, and recyclability via synergistic roles of multiple dynamic bonds
DOI: 10.1039/D5GC04554A, PaperYuzhao Qi, Yinliang Zhang, Shiyu Ou, Guangwu Zhuo, Hongju Zeng, Yufei Lao, Junfeng Wang, Qingwen Wang, Chuigen Guo
Complementary functions and synergy between multiple dynamic covalent bonds to construct the itaconic acid-based epoxy vitrimers with functional customisation.
To cite this article before page numbers are assigned, use the DOI form of citation above.
The content of this RSS Feed (c) The Royal Society of Chemistry
An Unexpected Transition-Metal Free Regioselective Cyclization of Alkynyl-Tethered Indoles to Prepare Indole-Fused Azepino[2,1-b]quinazolinones and Spiroindole-pyrrolo[2,1-b]quinazolinones
DOI: 10.1039/D5GC04267D, PaperPei-Sen Zou, Yi-Fan Geng, Xiao-Qing Liu, Jun-Cheng Su, Cheng-Xue Pan, Dong-Liang Mo, Gui-Fa Su
We report an unexpectedly transition-metal free and base-promoted regioselective cyclization of N3-alkynyl-2-indolylquinazolinones for the efficient synthesis of various indole-fused azepino[2,1-b]quinazolinones and spiroindole-pyrrolo[2,1-b]quinazolinones in good to excellent yields under mild reaction...
The content of this RSS Feed (c) The Royal Society of Chemistry
Chalcogenide electrocatalysts for electrolytic seawater oxidation: design strategies for enhanced activity and selectivity
DOI: 10.1039/D5GC03454J, Tutorial ReviewQing Li, Chenxi Liu, Zefeng Teng, Rui Zhang, Xu Liu, Jia Liu, Zhenyu Xiao, Jingqi Chi, Jianping Lai, Lei Wang
This review systematically summarizes recent advances in chalcogenide-based catalysts for OER in seawater, focusing on strategies for enhancing their activity and chloride inhibition capabilities.
To cite this article before page numbers are assigned, use the DOI form of citation above.
The content of this RSS Feed (c) The Royal Society of Chemistry
Recent Advancements in Microbial Carbon Dioxide Fixation: Metabolic Engineering Strategies
DOI: 10.1039/D5GC03349G, Tutorial ReviewZeeshan Mustafa, Naeem Auroona, Arslan Sarwar, Eun Yeol Lee
Global warming driven by rising CO2 emissions has spurred intense interest in biological carbon fixation as a sustainable alternative to physicochemical approaches. This review explores natural, engineering, and synthetic CO2...
The content of this RSS Feed (c) The Royal Society of Chemistry
Scalable Green Sustainable Photosynthesis of H2O2: Catalyst-free H Radical Generation and ORR Under Sunlight
DOI: 10.1039/D5GC04018C, PaperMeng Liu, Qi Miao, Xiao-Yuan Zhou, Dan Luo, Hong-Li Wei, Pan Wu, Changjun Liu, Wei Jiang
Hydrogen peroxide (H2O2) sunlight-driven green synthesis is a desirable demand, but current photo-catalysis fail to meet industry demand due to slow rate, excessive oxidation and uneconomic steps. This study proposes...
The content of this RSS Feed (c) The Royal Society of Chemistry
Green and robust chitin hydrogel toward high-performance Zn anode for sustainable energy storage
DOI: 10.1039/D5GC03960F, PaperYuyang Yan, Haodong Zhang, Yanbo Zhu, Xiaotang Gan, Jinping Zhou
Aqueous zinc batteries (AZBs) have garnered significant attention for green energy storage due to their inherent advantages in high environmental compatibility and low cost. However, challenges such as uncontrollable Zn...
The content of this RSS Feed (c) The Royal Society of Chemistry
Electrochemical reconstruction- and electronegativity-induced electron redistribution for activating sulfur atoms of MoOxSy-based materials toward efficient hydrogen evolution
DOI: 10.1039/D5GC03386A, PaperXiao-Yu Yang, Rui-Yuan Li, Zhan Liu, Chunmu Guo, Xiaoyun Li, Cuifang Ye, Zhao Deng, Jia-Min Lyu, Ming-Hui Sun, Shen Yu, Yu Li, Yiyong Huang, Li-Hua Chen, Kai Liu, Bao-Lian Su, Yi-Long Wang
Amorphous MoOxSy compounds have attracted considerable attention in the field of hydrogen evolution reaction (HER) due to their unique structural advantages, which include the retention of high electrical conductivity of...
The content of this RSS Feed (c) The Royal Society of Chemistry
Coordination Regulation of Single-Atom Catalysts toward Enhanced Photocatalytic Ammonia Synthesis
DOI: 10.1039/D5GC04101E, Tutorial ReviewRong Tang, Hu Guo, Wei Jiang, Jun Di
Photocatalytic ammonia synthesis is a sustainable pathway to substitute the Haber-Bosch reaction where high energy consumption exists, and single-atom catalysts (SACs) are pivotal materials in this field rely on their...
The content of this RSS Feed (c) The Royal Society of Chemistry
Metal-free electrohalogenation of olefins with aqueous NaX mediators
DOI: 10.1039/D5GC04102C, CommunicationZhe Zhang, Quanjin Rong, Shengkang Qian, Jianyou Zhao, Chengling Deng, Jiaoyang Liu, Fan Wang, Shuai Liu, Zhong-Quan Liu
We have developed a practical and diverse chlorination of alkenes via metal-free electrochemistry. By simply tuning the substitution pattern of the alkene, selective access to vicinal dichlorides, monochlorides, or allylic chlorides can be achieved.
To cite this article before page numbers are assigned, use the DOI form of citation above.
The content of this RSS Feed (c) The Royal Society of Chemistry
One-pot three-component metal-free catalytic sustainable synthesis of pyrrole from biomass-derived amino alcohols
DOI: 10.1039/D5GC02784E, PaperSihan Zhao, Mei-tian Fu, Lu Yin, Zhou Zhang, Minglong Yuan, Chao Huang
This paper describes a method for the efficient and sustainable synthesis of renewable pyrroles from biomass-derived amino alcohols under metal-free catalytic conditions without the requiring additional solvents. The method is...
The content of this RSS Feed (c) The Royal Society of Chemistry
Expanding and recycling a water-resistant bioderived rigid foam using CO2-responsive amines and carbonated water
DOI: 10.1039/D4GC06165A, Paper
 Open Access
Open Access    This article is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported Licence.Daniel Barker, Michael F. Cunningham, Guojun Liu, Philip G. Jessop
  This article is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported Licence.Daniel Barker, Michael F. Cunningham, Guojun Liu, Philip G. JessopBy combining renewable resources with CO2-responsive functionalities, a sustainable foam packaging material was developed. This bioderived foam can be recycled by dissolving it into carbonated water and expanding it into a new foam product.
To cite this article before page numbers are assigned, use the DOI form of citation above.
The content of this RSS Feed (c) The Royal Society of Chemistry
From lignin to market: a technical and economic perspective of reductive depolymerization approaches
DOI: 10.1039/D5GC02316E, Critical Review
 Open Access
Open Access    This article is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported Licence.Brent Daelemans, Balaji Sridharan, Paul Jusner, Agneev Mukherjee, Jiazhao Chen, Jacob K. Kenny, Miet Van Dael, Karolien Vanbroekhoven, Peter J. Deuss, Michael L. Stone, Elias Feghali
  This article is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported Licence.Brent Daelemans, Balaji Sridharan, Paul Jusner, Agneev Mukherjee, Jiazhao Chen, Jacob K. Kenny, Miet Van Dael, Karolien Vanbroekhoven, Peter J. Deuss, Michael L. Stone, Elias FeghaliThe industrial potential of pilot-scale reductive depolymerization approaches is critically assessed from a technical, techno-economic, and application point of view.
To cite this article before page numbers are assigned, use the DOI form of citation above.
The content of this RSS Feed (c) The Royal Society of Chemistry
All-climate all-solid-state batteries enabled by high-entropy amorphous oxyhalide solid electrolytes
DOI: 10.1039/D5GC03551A, PaperShufeng Song, Wei Xue, Yumei Wang, Zhongting Wang, Yanming Cui, Zhixu Long, Hongyang Shan, Ning Hu, Jingfeng Wang, Fusheng Pan
A high-entropy mixed-ion strategy overcomes ASSBs’ temperature limits. The engineered high-entropy amorphous oxyhalide achieves high ionic conductivity (7.1 mS cm−1) and enhanced electrochemical stability, enabling all-climate ASSBs.
To cite this article before page numbers are assigned, use the DOI form of citation above.
The content of this RSS Feed (c) The Royal Society of Chemistry