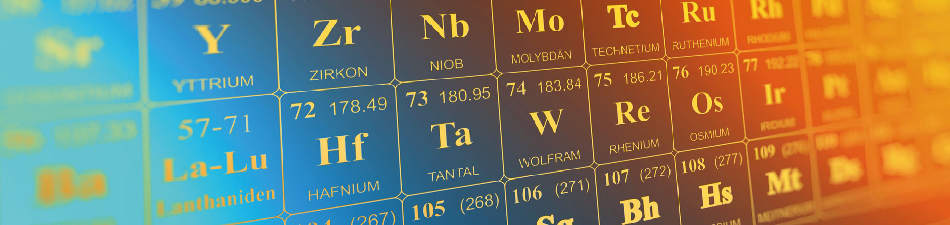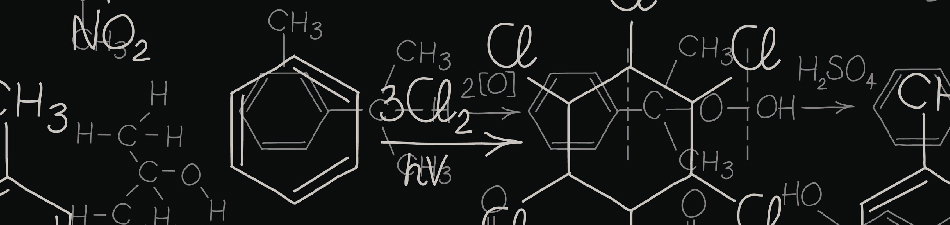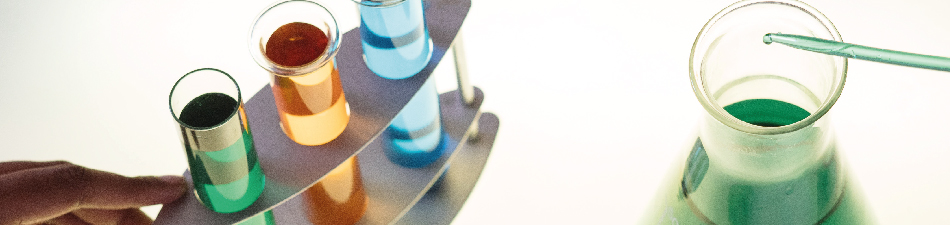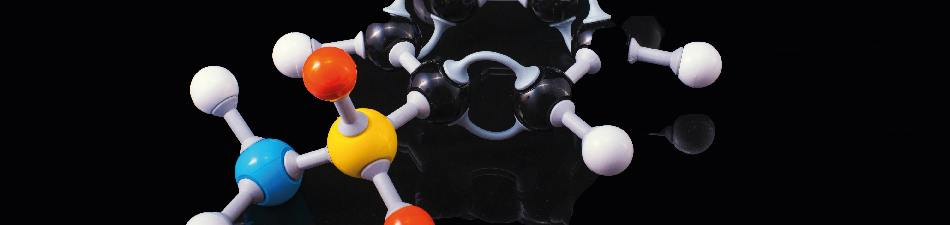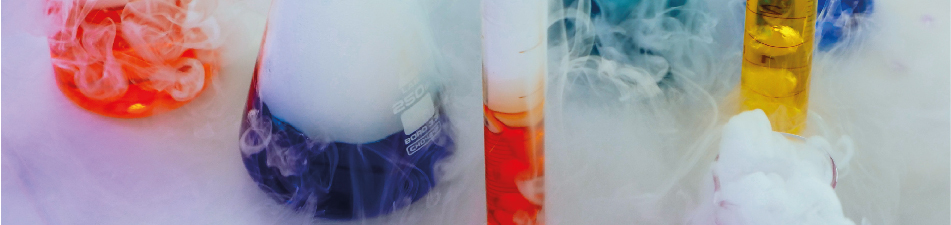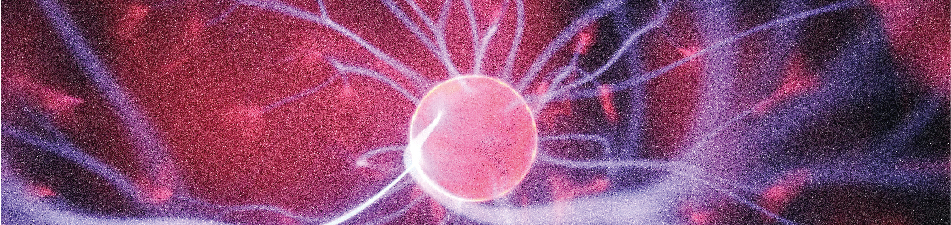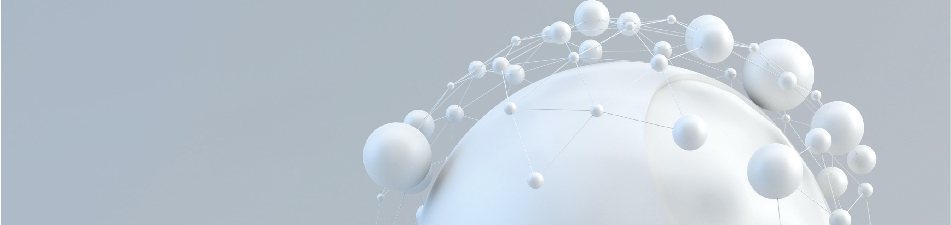Feed aggregator
Scalable green sustainable photosynthesis of H2O2: catalyst-free H radical generation and ORR under sunlight
DOI: 10.1039/D5GC04018C, PaperMeng Liu, Qi Miao, Xiaoyuan Zhou, Dan Luo, Hongli Wei, Pan Wu, Changjun Liu, Wei Jiang
The green closed-loop photosynthesis mechanism of H2O2 is catalyst-free. The radical generation via three pathways: prioritized active PA–O2 complexation with O2 present, highly selective O–H/C–H homolytic cleavage and a subsequent HAT process.
The content of this RSS Feed (c) The Royal Society of Chemistry
Advances in ionic liquid recycling for lignocellulosic biomass pretreatment
DOI: 10.1039/D5GC03051J, Critical Review
 Open Access
Open Access    This article is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported Licence.Md Maksudur Rahman, Hemant Choudhary, Blake A. Simmons, John M. Gladden, Alberto Rodriguez
  This article is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported Licence.Md Maksudur Rahman, Hemant Choudhary, Blake A. Simmons, John M. Gladden, Alberto RodriguezIn this review, we provide a comprehensive assessment of recent advances in ionic liquid recycling technologies.
To cite this article before page numbers are assigned, use the DOI form of citation above.
The content of this RSS Feed (c) The Royal Society of Chemistry
A green and robust chitin hydrogel toward a high-performance Zn anode for sustainable energy storage
DOI: 10.1039/D5GC03960F, PaperYuyang Yan, Haodong Zhang, Yanbo Zhu, Xiaotang Gan, Jinping Zhou
A green and robust chitin hydrogel facilitates the desolvation of hydrated Zn2+ ions and ensures homogeneous deposition, thereby effectively suppressing Zn dendrite formation and side reactions.
The content of this RSS Feed (c) The Royal Society of Chemistry
Coordination regulation of single-atom catalysts toward enhanced photocatalytic ammonia synthesis
DOI: 10.1039/D5GC04101E, Tutorial ReviewRong Tang, Hu Guo, Wei Jiang, Jun Di
This review systematically summarizes recent advances in single-atom regulation for enhanced photocatalytic ammonia synthesis, focusing on structure–property relationships.
The content of this RSS Feed (c) The Royal Society of Chemistry
SiC nanowire supported Pd for efficient flow hydrogenation of nitroarenes to arylamines
DOI: 10.1039/D5GC03554F, PaperAichun You, Weixian Lian, Xianliang Fu, Yuge Fan, Jinni Shen, Xuan Zhao, Li Zhu, Fan Tian, Man Xu
A highly efficient continuous-flow catalytic system for the ambient hydrogenation of nitroarenes to arylamines has been developed over Pd/SiC NWs.
The content of this RSS Feed (c) The Royal Society of Chemistry
One-pot three-component metal-free catalytic sustainable synthesis of pyrroles from biomass-derived amino alcohols
DOI: 10.1039/D5GC02784E, PaperSihan Zhao, Meitian Fu, Lu Yin, Zhou Zhang, Minglong Yuan, Chao Huang
This paper describes a method for the efficient and sustainable synthesis of renewable pyrroles from biomass-derived amino alcohols under metal-free catalytic conditions without the requirement of additional solvents.
The content of this RSS Feed (c) The Royal Society of Chemistry
Utilisation of Analytical Method Greenness Score to drive sustainable chromatographic method development
DOI: 10.1039/D5GC01574J, PaperFrancis Power, Paul Ferguson, Abigail Herbert, Sara Ryan, Matthew Osborne, Louie Trezise
Sustainability considerations are gaining prominence within the pharmaceutical industry, driven primarily by increased awareness of environmental impacts associated with pharmaceutical development and manufacturing.
The content of this RSS Feed (c) The Royal Society of Chemistry
Self-cleaning catalysts enable recycling of multilayered plastic films
DOI: 10.1039/D5GC02739J, Paper
 Open Access
Open Access    This article is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported Licence.Dai-Phat Bui, Shuheng Wang, Laura A. Gomez, Tahmid Ul Karim, Thomas S. Salas, Samira Abdolbaghi, Kevin Nelson, Lance L. Lobban, Christos T. Maravelias, Steven P. Crossley
  This article is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported Licence.Dai-Phat Bui, Shuheng Wang, Laura A. Gomez, Tahmid Ul Karim, Thomas S. Salas, Samira Abdolbaghi, Kevin Nelson, Lance L. Lobban, Christos T. Maravelias, Steven P. CrossleySelf-cleaning catalysts convert polyol impurities in multilayered films to polyolefin compatible streams.
The content of this RSS Feed (c) The Royal Society of Chemistry
Low-temperature modified-immersion molten ZnCl2-carbonization and activation for continuous production of mesoporous carbon from plastic waste
DOI: 10.1039/D5GC02465J, PaperTheerawat Waiyaka, Rungkiat Nganglumpoon, Chonticha Rajrujithong, Weerachon Tolek, Pui Vun Chai, Masayuki Shirai, Anuchit Wuttitrairat, Paisan Kittisupakorn, Joongjai Panpranot
We developed a prototype continuous MSCA system using a modified-immersion ZnCl2 molten salt process at 350 °C to convert common plastic waste (PP, PLA, and PET) into high-surface-area mesoporous carbon for energy storage applications.
The content of this RSS Feed (c) The Royal Society of Chemistry
Solvent-Less Environmentally Benign Amino Ester, Amide, and Peptide Synthesis Enabled by Resonant Acoustic Mixing
DOI: 10.1039/D5GC04619J, Paper
 Open Access
Open Access    This article is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported Licence.Nassim Maarouf-Mesli, Justin Desjardins-michaud, Zeynab IMANI, Kinshuk Ghosh, Felix Polyak, William D Lubell
  This article is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported Licence.Nassim Maarouf-Mesli, Justin Desjardins-michaud, Zeynab IMANI, Kinshuk Ghosh, Felix Polyak, William D LubellThe demand for sustainable methods for peptide synthesis grows imperatively with their escalating use in therapeutic and biomedical applications. The cornerstone technology of solidphase peptide synthesis has unsustainable environmental impact...
The content of this RSS Feed (c) The Royal Society of Chemistry
Hyperproduction of 3-hydroxybutyrate using engineered probiotic E. coli Nissle 1917 from glucose and CO2-derived acetate
DOI: 10.1039/D5GC03448E, PaperFu-Ren Yang, Ye Zheng, Rui-Zhe Deng, Lin Xia, Huai-Ming Wang, Yi-Hao Deng, Wei Situ, Yan-Chun Xiao, Hong-Wei Shen, Jin-Yan Lv, Liu-Song Yu, Hui Wang, Yi-Na Lin, Jian-Wen Ye
Hyperproduction of 3-HB (105 g L−1) was achieved using recombinant EcN with glucose and CO2-derived acetate with a significantly reduced carbon footprint.
To cite this article before page numbers are assigned, use the DOI form of citation above.
The content of this RSS Feed (c) The Royal Society of Chemistry
Integrating catalytic fractionation and microbial funneling to produce 2-pyrone-4,6-dicarboxylic acid and ethanol
DOI: 10.1039/D5GC03986J, Paper
 Open Access
Open Access    This article is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported Licence.Canan Sener, Emmanuel A. Aboagye, Steven D. Karlen, Jose M. Perez, German E. Umana, Yaoping Zhang, José Serate, Timothy J. Donohue, Daniel R. Noguera, Christos T. Maravelias
  This article is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported Licence.Canan Sener, Emmanuel A. Aboagye, Steven D. Karlen, Jose M. Perez, German E. Umana, Yaoping Zhang, José Serate, Timothy J. Donohue, Daniel R. Noguera, Christos T. MaraveliasConcerted biomass fractionation and lignin depolymerization process integrated with microbial funneling to PDC, ethanol, and electricity results in a 29% reduction in the minimum selling costs for PDC and reduced environmental impact.
To cite this article before page numbers are assigned, use the DOI form of citation above.
The content of this RSS Feed (c) The Royal Society of Chemistry
A feasible methanol economy for a green future
DOI: 10.1039/D5GC04615G, Paper
 Open Access
Open Access    This article is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported Licence.Hidde Kolmeijer, Abhinandan Nabera, Antonio J. Martín, Gonzalo Guillén-Gosálbez, Javier Pérez-Ramírez
  This article is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported Licence.Hidde Kolmeijer, Abhinandan Nabera, Antonio J. Martín, Gonzalo Guillén-Gosálbez, Javier Pérez-RamírezThis study models a future methanol economy where combining biomass, biogas, and air-captured CO2 achieves net-zero emissions at about 32 USD2025 per person per month, close to Paris Agreement-aligned costs while delivering deeper emission cuts.
To cite this article before page numbers are assigned, use the DOI form of citation above.
The content of this RSS Feed (c) The Royal Society of Chemistry
CO2-affinitive surface of metal/Nafion attributable to selective polarization for superior CO2RR
DOI: 10.1039/D5GC04074D, PaperXianda Zhang, Yaotian Yan, Yangshuo Liu, Chun Li, Jian Cao, Junlei Qi
Nafion was recognized as not only a binder component but also a transporter for CO2 on the surface of a metal catalyst.
To cite this article before page numbers are assigned, use the DOI form of citation above.
The content of this RSS Feed (c) The Royal Society of Chemistry
Molecular property prediction for very large databases with natural language processing: a case study in ionic liquid design
DOI: 10.1039/D5GC02803E, Paper
 Open Access
Open Access    This article is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported Licence.Mood Mohan, Michelle K. Kidder, Jeremy C. Smith
  This article is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported Licence.Mood Mohan, Michelle K. Kidder, Jeremy C. SmithHerein, we report the development of machine learning models for predicting the properties of ionic liquids using Mol2vec featurization technique and this approach enables accelerated development of ILs with optimal properties.
To cite this article before page numbers are assigned, use the DOI form of citation above.
The content of this RSS Feed (c) The Royal Society of Chemistry
Visible-light-driven valorization of biomass-derived furfuryl alcohol to diesel precursors with simultaneous H2 evolution over a dual functional In2S3–Zn5In2S8 photocatalyst
DOI: 10.1039/D5GC04034E, PaperYibei Zhang, Hongyun Lu, Xuekai Qu, Lunan Wu, Zhenghao Song, Xinyi Ding, Peng Li, Xiu-Jie Yang, Dong Liu
Solar-driven In2S3–Zn5In2S8 heterostructures enable simultaneous furfuryl alcohol coupling and H2 production without sacrificial agents, offering a green route for biomass valorization and solar fuel coproduction.
To cite this article before page numbers are assigned, use the DOI form of citation above.
The content of this RSS Feed (c) The Royal Society of Chemistry
Correction: A dynamic sulfur-rich network from silicone industry waste
DOI: 10.1039/D5GC90203G, Correction
 Open Access
Open Access    This article is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported Licence.Zixiao Wang, Yuanyuan Qiu, Zheju Cheng, Honglu Huang, Yang Sui, Xin Liu, Yijie Yang, Yue Lu, Huie Zhu, Qingqing Ji, Jiajun Yan
  This article is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported Licence.Zixiao Wang, Yuanyuan Qiu, Zheju Cheng, Honglu Huang, Yang Sui, Xin Liu, Yijie Yang, Yue Lu, Huie Zhu, Qingqing Ji, Jiajun YanThe content of this RSS Feed (c) The Royal Society of Chemistry
Room-temperature chromatographic H2/D2 separation via a solid dihydrogen complex with balanced thermodynamics and kinetics
DOI: 10.1039/D5GC04476F, Paper
 Open Access
Open Access    This article is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported Licence.Tamon Yamauchi, Taku Kitayama, Kaiji Uchida, Nino Keuzenkamp, Hiroaki Iguchi, Ryojun Toyoda, Ryota Sakamoto, Hao Xue, Naoki Kishimoto, Shin-ichiro Noro, Shinya Takaishi
  This article is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported Licence.Tamon Yamauchi, Taku Kitayama, Kaiji Uchida, Nino Keuzenkamp, Hiroaki Iguchi, Ryojun Toyoda, Ryota Sakamoto, Hao Xue, Naoki Kishimoto, Shin-ichiro Noro, Shinya TakaishiMn-PCy3 showed the highest H2/D2 separation ability among known materials due to a large difference in ZPVE. D2 separation with pressure swing adsorption using Mn-PCy3 could be achieved with ∼1/10 of the energy cost for distillation.
To cite this article before page numbers are assigned, use the DOI form of citation above.
The content of this RSS Feed (c) The Royal Society of Chemistry
Il piano UE per la Chimica.
Luigi Campanella, già Presidente SCI
Nel recente mese di luglio, forse presi dalle vacanze vicine, è scappato ai commenti il nuovo piano per la Chimica della Commissione Europea.
Questo viene dopo quelli dei settori automobilistico e siderurgico. L’importanza del settore chimico viene oltre che dalla sua posizione, la quarta, nella classifica dei settori manifatturieri, anche dal numero di imprese europee in esso operanti, 29000, e dal numero di lavoratori, 1.200.000, che sostengono 19 milioni di Europei (le loro famiglie). Il piano affronta 3 importanti sfide: abbattimento dei costi energetici, concorrenza extra europea e debolezza della domanda, promuovendo responsabilità, sostenibilità ed innovazione.
All’interno del piano è anche presente una semplificazione normativa e legislativa delle sostanze chimiche con potenziamento dell’economia.

Sono 4 le misure proposte che compongono il piano.
La prima viene individuata come Resilienza di un’alleanza chimica europea per la identificazione dei siti produttivi critici, soprattutto con riferimento all’aspetto commerciale;
la seconda è finalizzata a disporre di risorse energetiche con norme chiare anche a protezione e sviluppo di nuove fonti, idrogeno in primis;
la terza è concentrata su incentivi e misure fiscali indirizzati alla decarbonizzazione;
la quarta punta alla riduzione delle emissioni dei PFAS.
Le misure secondo gli estensori del Piano dovrebbero garantire risparmi per 363 milioni di euro l’anno. Per quanto si riferisce alla semplificazione per ridurre i costi di conformità e gli oneri amministrativi per l’industria chimica, garantendo nel contempo un’elevata protezione della salute umana e dell’ambiente, rientrano in tale contesto varie iniziative.
La prima è la semplificazione delle norme relative all’etichettatura delle sostanze chimiche pericolose; seguono il chiarimento delle normative dell’UE sui cosmetici e l’agevolazione della registrazione dei prodotti fertilizzanti dell’UE mediante l’allineamento alle norme REACH.
È vero che per un’Europa forte, competitiva e sicura, abbiamo bisogno di un settore chimico fiorente, ma la protezione della salute delle persone e dell’ambiente deve andare di pari passo con il successo delle imprese.
Il rischio è che mediante il piano d’azione europeo per l’industria chimica si semplifichino le norme e si applichi una logica assistenzialistica industriale a danno della protezione della salute e dell’ambiente e della innovazione e circolarità.
Per approfondire:
https://single-market-economy.ec.europa.eu/document/download/e5006955-dd1c-45bc-8b7a-cfda71c67abf_en?filename=COM_2025_530_1_EN_ACT_part1_v6.pdf il testo del piano
https://cen.acs.org/policy/trade/European-chemical-industry-action-plan/103/web/2025/07
un commento di C&E news
Translating lobby speak: What chemical industry’s ‘simplification’ plan really meansuna critica ambientalista

Le Cose della Chimica e i loro Nomi.
1.Atomo
Silvana Saiello
La Chimica, questa sconosciuta!
Quali sono le difficoltà di comprensione della Chimica?
A questa domanda le risposte che ho ascoltato nel tempo sono le più disparate. Al di là della complessità della disciplina che spazia in amplissimi ambiti della ricerca e della conoscenza scientifica, esiste un problema di parole pronunciate troppo spesso senza conoscerne il significato.
La legittimazione da parte degli insegnanti a continuare a ripetere parole di cui lo studente ignori il significato legittima l’incomprensibilità della disciplina
Ci sono alcune parole di Chimica che sono utilizzate quasi quotidianamente da persone che ne ignorano il significato.
Ai miei studenti del primo anno di Università negli ultimi dieci anni del mio lavoro, proponevo la domanda che segue:
Quale immagine o idea si forma nella vostra mente quando ascoltate queste parole?
Le parole sono
1.Atomo,
2.Molecola,
3.Sostanza Semplice,
4.Sostanza Composta,
5.Formula Chimica,
6.Reazione Chimica,
7.Soluzione,
8.Solubilità
La scelta è caduta su queste otto parole perché se tutti gli studenti della mia classe avessero avuto consapevolezza di quali di queste parole conoscessero o meno il significato, il mio lavoro sarebbe stato molto semplificato. Purtroppo un numero molto molto limitato di studenti rispondeva in maniera adeguata, maniera che, come dicevo loro avrebbe potuto anche essere: Nessuna idea. Purtroppo questa risposta che denoterebbe una buona consapevolezza era un evento che non si è manifestato mai.

D’altro canto gli studenti hanno grande difficoltà a rispondere correttamente a una domanda la cui risposta è Zero o Nessuna cosache ritengo denoti una quasi completa assenza del pensiero critico, ma questa è un’altra storia e si racconterà un’altra volta.
La scelta è ricaduta su queste parole perché appartengono ai tre contesti nei quali è possibile inquadrare quasi tutti i concetti della Chimica.
Il contesto Macroscopico (Sostanza Semplice, Sostanza Composta, Soluzione, Solubilità) , quello Submicroscopico[1] (Atomo, Molecola) e quello Simbolico (Formula Chimica, Reazione Chimica).
Queste parole/concetti possono e devono richiedere livelli di approfondimento diversi durante il percorso scolastico da parte dei docenti, ma dal mio punto di vista, è possibile raccontarne una storia semplice anche ai primi stadi della formazione scolastica
Cominciamo da una parola molto conosciuta ATOMO.
Vorrei proporre una riflessione critica sulla costruzione di questo concetto non necessariamente in un percorso scolastico
E’ innanzitutto molto importante distinguere la conoscenza di una parola dalla conoscenza del suo significato. Troppo spesso questi due piani vengono sovrapposti e si confonde la conoscenza della parola con quella del suo significato.
Atomo: che cosa mi piacerebbe che una persona che ha concluso gli studi della scuola superiore conoscesse di questo “oggetto”.
Innanzitutto che è un oggetto talmente piccolo che non si riesce a vedere direttamente nemmeno con il più potente dei microscopi, che della sua esistenza si hanno solo prove indirette, che ogni Atomo “caratterizza” una Sostanza semplice[2]
Ma che cosa vuol dire caratterizza?
Stiamo mettendo nella stessa frase una parola/concetto che appartiene al contesto sub microscopico e una che appartiene al contesto macroscopico. Evidentemente ci deve essere una relazione tra i due contesti.
Cerchiamo di capire meglio.
Di Atomo si è cominciato a parlare nell’antichità quando i filosofi si cominciarono a chiedere se fosse possibile spezzettare gli oggetti in parti sempre più piccole. Ci sono state molte speculazioni di uomini di pensiero che si sono occupati di Atomi.

Slide 19 di Silvana Saiello
Molto interessante sarebbe discutere con gli insegnanti di lettere o filosofia sugli scritti nei quali si cominciava a parlare di Atomi un esempio per tutti il De rerum natura di Tito Lucrezio Caro
Quando parliamo di Atomi chiediamo agli studenti di credere a quello che affermiamo noi mentre dovremmo essere in grado di mettere gli studenti nelle condizioni di porsi domande e cioè di chiedersi e chiederci se abbiamo qualche prova indiretta o almeno qualche indizio della loro esistenza.
Prima di parlare di Atomi, però, bisognerebbe avviare una riflessione critica sulla natura particellare della materia discutendo il comportamento di un sistema gassoso.
Prima di parlare di Atomi dovremmo anche convincere i nostri interlocutori non solo che la materia è fatta di particelle [3] , ma anche che esistono le Sostanze semplici che sono diverse dalle Sostanze composte.
I contesti si avvicinano.
La mia proposta, nel percorso che proponevo ai miei studenti del primo anno del corso di laurea in ingegneria, parte da un racconto semplificato del ruolo che hanno avuto i numeri nella definizione delle leggi fondamentali della Chimica.
Chiamavo questa parte del percorso: I numeri la voce dei fatti.

Slide 23 di Silvana Saiello
Per gli interessati metto a disposizione le slide relative a questa parte del mio corso.
Alla prossima per la parola Molecola
[1] invisibile ai comuni microscopi
[2] Di ELEMENTO, si parlera’ in un’altra occasione
[3] Se vogliamo che un bambino della scuola primaria pronunci la parola Atomo in maniera consapevole dobbiamo innanzitutto convincerlo della Natura particellare della Materia, quindi discutere con lui su che cosa si intende per Materia e come mai ci siamo convinti che sia costituita da particelle piccole piccole che non riusciamo a vedere, con la consapevolezza che queste particelle non sono Atomi
[Un possibile percorso potrebbe essere quello di lavorare sull’evaporazione in particolare dell’Acqua]