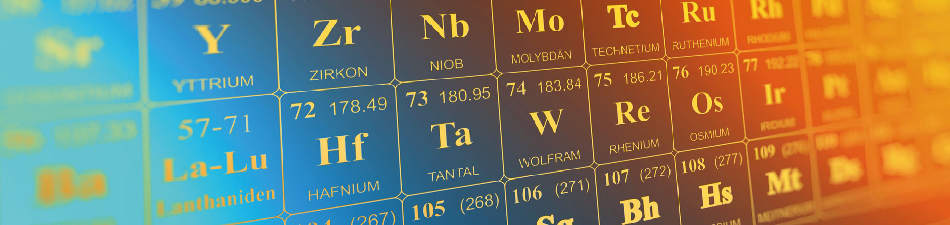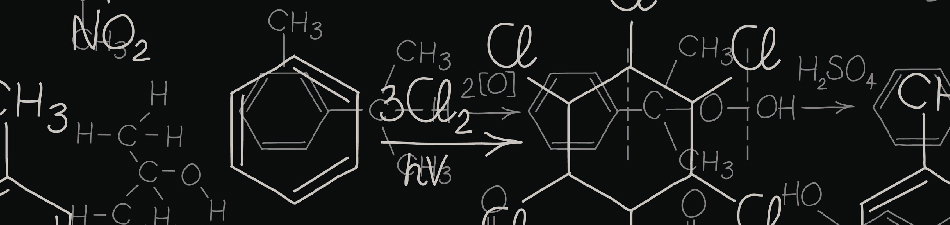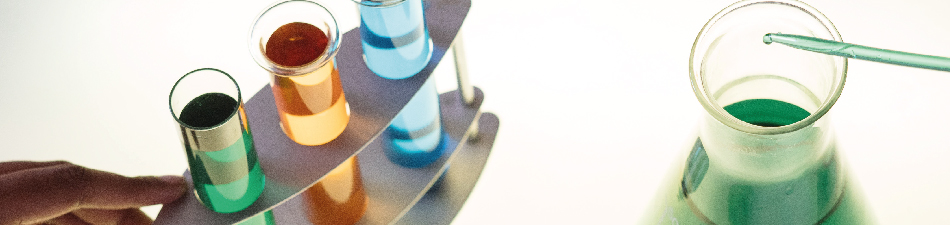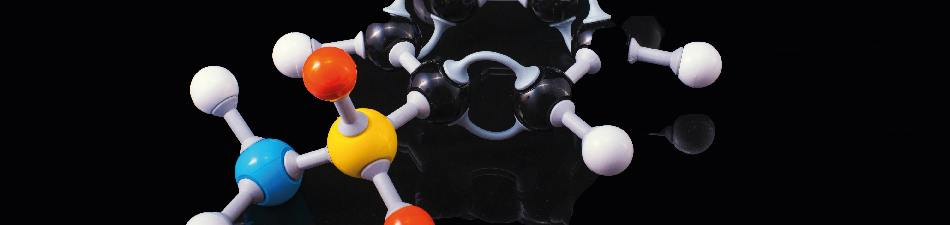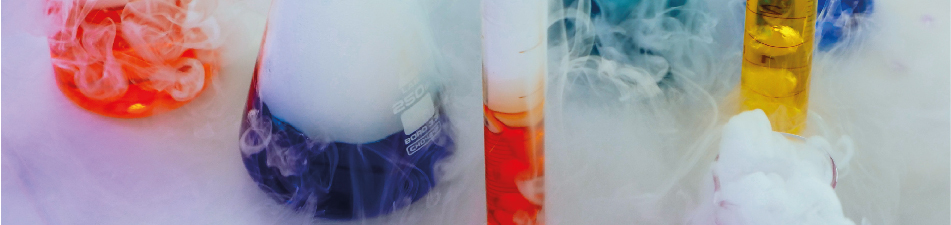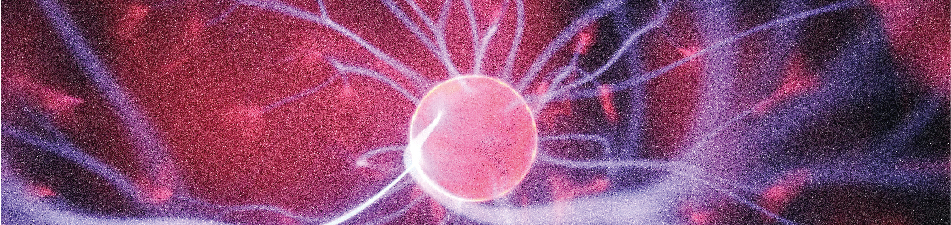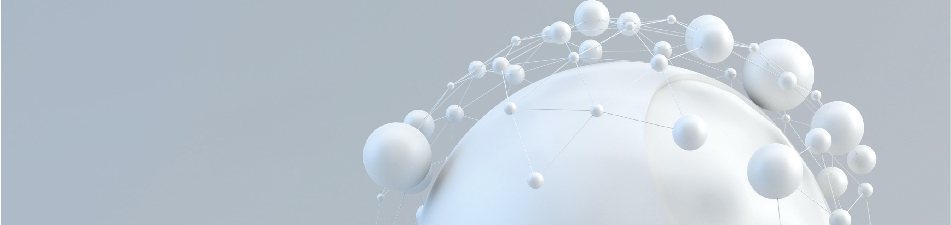Spettroscopio a due prismi
Spettroscopio (Acquistato in data 21.11.1887 da Ph. Pellin (fornitore)
Strumento che consente di disperdere la radiazione luminosa in uno spettro, che viene poi osservato e analizzato. I primi strumenti furono costruiti nel 1859 in Germania da Bunsen e Kirchhoff. Prima, le osservazioni spettroscopiche erano eseguite con semplici prismi o reticoli di diffrazione.
Isaac Newton fu uno dei primi (1666) a utilizzare un prisma di vetro per analizzare la luce bianca, scindendola in sette colori e dimostrando che essi non potevano essere ulteriormente scomposti. Nel 1810, il vetraio bavarese Joseph von Fraunhofer trovò che gli spettri di fiamma sono caratterizzati da linee brillanti discrete. Trovò anche , nello spettro solare, delle linee scure, poi chiamate linee di Fraunhofer, la cui posizione si manteneva invariata.
Nel 1826 William Henry Fox Talbot suggerì che le linee spettrali potessero essere usate per l’analisi Chimica, ma l’idea non ebbe seguito, sia perché la bassa qualità dei prismi rendeva impossibile l’ottenimento di risultati riproducibili, sia per le impurezze presenti nei reattivi chimici.
L’idea fu ripresa negli anni ’60 da Robert Wilhelm Bunsen (1824-1887), professore a Heidelberg, che si rese conto del fatto che la luce emessa dalle fiamme fosse caratteristica specifica degli elementi chimici presenti nelle fiamme. Così, negli anni tra il 1860 e il ’61, insieme a Gustav Robert Kirchhoff (1811-1899), identificò, nelle acque minerali di Dürkheim, due nuovi elementi, che chiamò rubidio e cesio dal colore della loro riga principale. Dall’evaporazione di 44.000 chili d’acqua, guidati dall’aumento di intensità delle righe spettrali, alla fine separarono 16,5 grammi di una miscela dei due cloruri [Holleman].
Lo spettroscopio è costituito da un prisma a base triangolare di vetro flint, con facce rifrangenti, la cui base inferiore è fissata al centro di un piatto metallico, che sostiene anche tre tubi. La luce da analizzare è fatta passare attraverso un tubo collimatore, che porta, all’estremità rivolta verso la fiamma, una fenditura verticale; essa, nella prima versione di Bunsen e Kirchhoff, era praticata su un foglio di stagno, poi fu sostituita da un dispositivo che, per mezzo di una vite micrometrica, riduceva la fenditura al minimo possibile, per ottenere uno spettro molto puro. All’altra estremità del tubo collimatore, è posta una lente convergente che rende i raggi paralleli, per regolazione opportuna della lunghezza del tubo collimatore, fino a farli collidere sul prisma, dove subiscono la diffrazione. Un secondo tubo porta all’estremità esterna una finestra di vetro, sulla quale è stampata una scala con le divisioni e i numeri trasparenti su fondo scuro, illuminata da una sorgente qualunque (per esempio, una candela) posta davanti all’estremità del tubo. Il terzo tubo è costituito da un cannocchiale astronomico, il cui obiettivo produce nel proprio piano focale un’immagine reale dello spettro, ingrandita attraverso l’oculare.
Gli assi del tubo che porta la scala e del cannocchiale colpiscono al centro una delle facce del prisma e sono egualmente inclinati rispetto ad essa, mentre l’asse del tubo collimatore passa in mezzo alla seconda faccia; il risultato di questa disposizione è che lo spettro di diffrazione si forma nello stesso punto nel quale l’immagine della scala è prodotta per riflessione, in modo da vedersi simultaneamente [Fresenius].
Nella Collezione storica di strumenti di Chimica dell’Università degli Studi di Palermo sono conservati due spettroscopi, uno a singolo prisma, inventariato al n° 379, anteriore al 1881, e uno a doppio prisma, registrato al n° 914 dell’inventario, acquistato in data 21 novembre 1887, dal fornitore francese Ph. Pellin. L’uso di due o più prismi, talvolta di materiali differenti, uniti fra loro in posizione permanente, consentiva di ottenere una più forte dispersione delle righe [Oddo].
Bibliografia
Robert Bud, Deborah Jean Warner, Instruments of Science, Garland Publishing Inc., New York and London (1998), pag 564
R. Fresenius, Traité d’Analyse Chimique Qualitative, Masson et Cie Editeurs, Paris (1897), pag 37
A. F. Holleman, Trattato di Chimica Inorganica, Società Editrice Libraria, Milano (1928), pag 374
Giuseppe Oddo, Trattato di Chimica Generale e Inorganica, Tipografia nazionale Stefano Casentino, Palermo, Terza Edizione, pagg 102 e 103