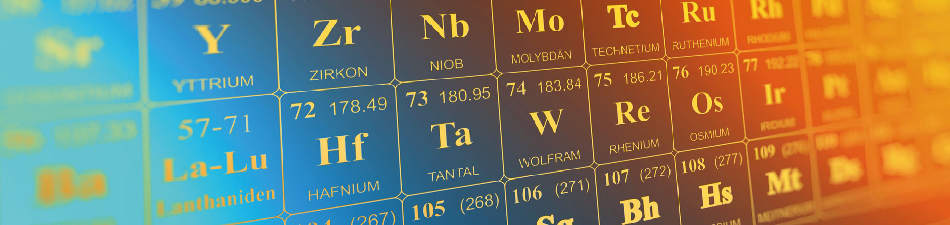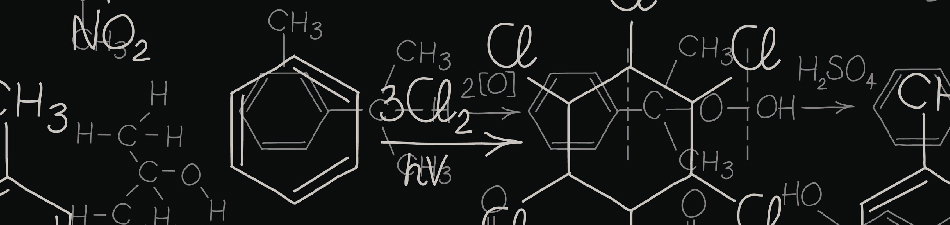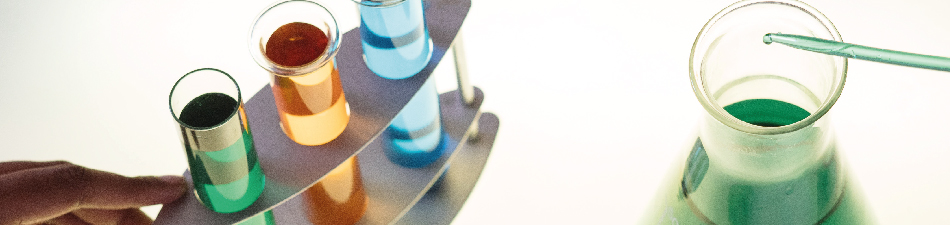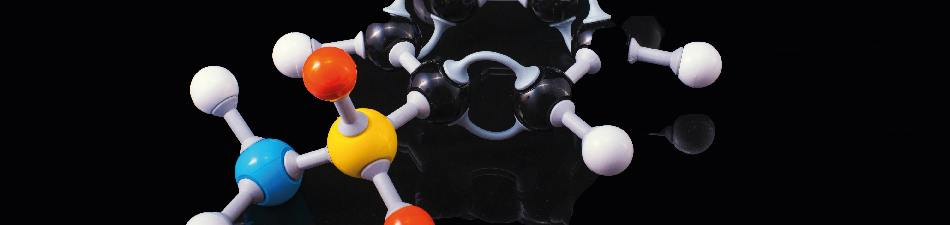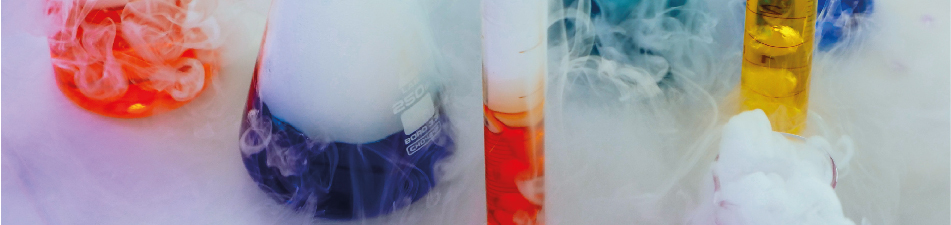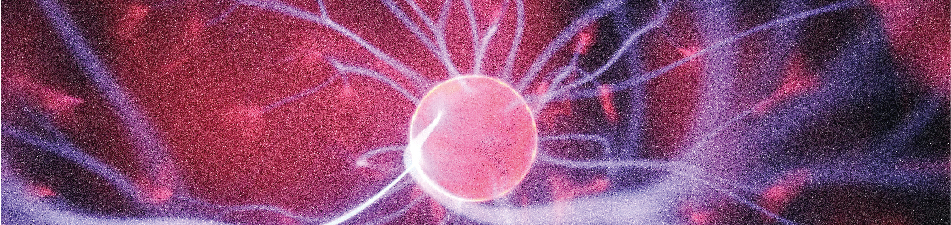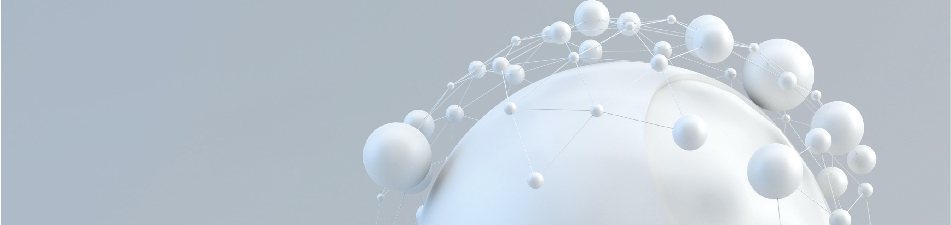Aerometri
Areometro (Scatola con 19 pezzi acquistati in data 10.11.1888 da Robert Muenke (fornitore)
L’areometro (o idrometro) misura il peso specifico di un liquido che, nel caso di miscele di liquidi o soluzioni, può essere messo in relazione con la loro composizione.
Questo dispositivo è menzionato da Ipazia nel 400 d.C. e dal poeta Remnio tre secoli prima. Nel tardo Medio Evo era usato in Germania per determinare la concentrazione delle salamoie. Robert Boyle lo introdusse nella pratica scientifica intorno al 1675. Nel XVIII secolo era usato soprattutto per l’analisi delle acque minerali e per determinare il grado alcolico delle bevande, a fini commerciali e fiscali.
L’areometro è costituito da un bulbo zavorrato con pallini di piombo o mercurio, sfilato verso l’alto in un lungo tubo chiuso e graduato. I più antichi modelli pervenutici, risalenti al XVII secolo, erano fatti di avorio appesantito con pallini da caccia. Nel 1675 John Clarcke utilizzò per l’analisi degli alcolici, areometri di rame. Alla cui base potevano essere avvitati pesi di diverso valore, per l’analisi di liquidi di differente densità.
Nel 1768 Lavoisier progettò un areometro per scopi fiscali, mentre il farmacista parigino Antoime Baumé ne costruì parecchi, per usi chimici e farmaceutici, e le scale da lui stabilite per l’analisi dei liquidi più pesanti e più leggeri dell’acqua furono usate per parecchi anni. Nel 1805, il medico berlinese Johann Georg Tralles studiò la relazione tra la gradazione alcolica e il peso specifico, proponendo una scala idrometrica che ebbe ampia diffusione nei paesi a lingua tedesca. Nel 1822 Joseph Louis gay-Lussac, sulla base di ulteriori indagini sulla relazione tra grado alcolico e densità, costruì un idrometro a scala centesimale.
La diffusione dell’uso di questi strumenti non era legata solo ai controlli fiscali, ma a veri e propri controlli industriali del prodotto, per garantirne la costanza delle caratteristiche. Si costruirono perciò areometri dedicati a particolari determinazioni, come il saccarometro, che misura il peso specifico dei mosti, il lattodensimetro, per la misura del potere nutritivo del latte, l’oleometro, per l’analisi degli oli, l’urinometro, per rivelare il diabete, l’acetometro, per determinare la forza dell’aceto, e molti altri. Essi avevano forma simile, spesso di vetro non corrodibile, ma differivano nelle rispettive scale idrometriche.
Lo strumento viene immerso nel liquido e lo si lascia galleggiare liberamente, leggendo sulla scala graduata il livello di affioramento. Per misure più accurate, si usa una serie di areometri da tubo sottile, in modo che ciascuno serva solo per un determinato intervallo di valori [Ostwald].
La scala Baumé è una scala arbitraria, il cui punto di zero è determinato dalla densità dell’acqua pura e il valore 10° da quella di una soluzione di cloruro di sodio al 10%. In questa scala, la densità dell’acido solforico puro corrisponde a 66,6°B [Hollemann]. La conversione dei gradi Baumé in densità si effettua tramite la relazione:
d = 144,3/(144,3 - °B)
Bibliografia
Robert Bud, Deborah Jean Warner, Instruments of Science, Garland Publishing Inc., New York and London (1998), pagg 311-312
A. F. Holleman, Trattato di Chimica Inorganica, Società Editrice Libraria, Milano (1928), pag 136
Ostwald-Luther, Misure Chimico-Fisiche, Teoria e Pratica, Ulrico Hoepli, Milano (1930) pag 168